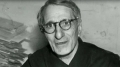Giugno 2013 Marie Curie seconda parte
notizia pubblica il 23/06/2013 - ultimo aggiornamento del 23/06/2013
CASA CULTURALE DI SAN MINIATO BASSO
www.casaculturale.it (sezione LETTURE)
GIUGNO 2013
MARIA CURIE 2a PARTE
La vita della grande scienziata dai libri di Eva Curie e Franca Gambino
LA TESI DI LAURA DI MARIA ALLA SORBONA
Il 25 giugno del 1903 sono ormai passati oltre cinque anni da quando Maria ha iniziato la sua tesi di laurea.
Trasportata nel turbine d’una scoperta immensa, essa ha lungamente procrastinato l’esame di laurea per il quale non aveva il tempo materiale di riunir gli elementi.
La signora Curie è in piedi, molto dritta. Sul suo volto pallido, sulla sua gran fronte che i capelli chiari, rialzati come un casco, scoprono interamente, qualche ruga segna le tracce della lotta ch’essa ha sostenuto e vinto.
Uomini di scienza, fisici e chimici, affollano la stanza. L’interesse eccezionale delle ricerche di cui sta per discutere ha attirato lì tutti quegli scienziati.
Il signor Lippmann, presidente, pronuncia la formula consacrata: “L’Università di Parigi le accorda il titolo di dottore in scienze fisiche, con la menzione “molto onorevole” e a nome della giuria , signora, ci tengo a esprimerle tutte le nostre felicitazioni”.
NIENTE BREVETTO ! SAREBBE CONTRARIO ALLO SPIRITO SCIENTIFICO
La Buffalo Society of Natural Science degli Stati Uniti si fece avanti per avere l’esclusiva della produzione del radio e naturalmente offriva grosse cifre ai coniugi Curie che avrebbero dovuto però, prima, brevettare la loro scoperta.
Maria e Pietro dissero senza alcuna esitazione che secondo loro “Gli scienziati pubblicano sempre integralmente le loro ricerche. Se la nostra scoperta ha un avvenire commerciale, questo è un caso del quale noi non dobbiamo approfittare”.
“D’accordo con me” scriverà Maria venti anni dopo “ Pietro Curie rinunciò a trarre un profitto materiale dalla nostra scoperta. Non prendemmo alcun brevetto e pubblicammo senza riserva alcuna i risultati delle nostre ricerche. Questo è stato un grande beneficio per l’industria del radio la quale ha potuto svilupparsi in piena libertà, prima in Francia e poi all’estero”.
IL PREMIO NOBEL
Tantissimi i riconoscimenti ufficiali in ogni nazione del valore dei coniugi Curie e naturalmente non poteva mncare il Premio Nobel.
Per non smentirsi nemmeno questa volta il Premio Nobel per la fisica dell’anno 1903, diplomi e medaglie d’oro, per i coniugi Maria e Pietro Curie, furono ritirati in Svezia dal Ministro francese. Pietro scrisse al segretario perpetuo del premio professor Aurivillius : “ …… non ci sarebbe possibile assentarci a quell’epoca dell’anno senza recare un turbamento assai grande all’insegnamento ch’è affidato a ciascuno di noi…….”
19 APRILE 1906 – LA GRAN DISGRAZIA PIOMBA SULLA CASA CURIE
Pietro verso le due e mezzo del pomeriggio, s’alza, saluta i colleghi e si appresta a ritornare a casa, come sempre a piedi. Sulla soglia guarda macchinalmente in aria e fa una smorfia dinanzi al cielo coperto. Coprendosi col suo grande ombrello, s’avvia sotto la pioggia verso la Senna. Come è ingombra questa strada incassata nella vecchia Parigi! Cammina ora sul margine di pietra, ora sulla strada, col passo ineguale degli esseri che seguono le proprie meditazioni. Vuole ora attraversare la strada e raggiungere l’altro marciapiede. Con la rapidità di gesti dei distratti fa qualche passo a sinistra e va ad urtare in una bestia fumante, uno dei cavalli di un carro che incrocia un fiacre. Lo spazio che separa i due veicoli si restringe vertiginosamente e Pietro, sorpreso, con un movimento goffo, tenta d’aggrapparsi al pettorale del cavallo e questo si impenna. Le scarpe dell’uomo scivolano sull’asfalto lubrico. S’alza un grido, fatto di venti gridi d’orrore : Pietro è caduto sotto gli zoccoli dei grandi cavalli normanni. L’enorme massa del carro, trascinata dal suo peso di sei tonnellate fa ancora qualche metro e la ruota posteriore sinistra urta un debole ostacolo, lo schiaccia al passaggio: una fronte, una testa umana. La scatola cranica scoppia, una materia rossa e viscosa schizza da tutte le parti, nel fango: il cervello di Pietro Curie.
Maria ha perduto il suo compagno e il mondo ha perso un grande uomo.
Essa decide risolutamente di rimanere a Parigi e di lavorare con grande attenzione in laboratorio per preparare l’insegnamento che deve a breve inaugurare. Si tratta dell’incarico di lavoro alla Sorbona che era del suo Pietro. Un corso d’insegnamento che deve essere degno di lui. Maria riunisce i suoi quaderni , i suoi libri, compulsa le note lasciate dallo scienziato. Una volta di più si sprofonda nello studio.
COME EDUCARE LE FIGLIE IRENE ED EVA
Maria trasmette alle figlie il suo amore per le scienze e il suo amore per lo sforzo.
Insegna loro anche i metodi che una lunga carriera ha sviluppato in lei.
Virtuosa nel calcolo mentale, essa insiste perché i suoi protetti lo pratichino anch’essi. “Bisogna arrivare a non sbagliarsi mai” afferma; “il segreto è di non far troppo in fretta. E non si deve dire mai pulirò dopo. Non si deve insudiciare un tavolo durante una preparazione o un’esperienza”
IL SECONDO PREMIO NOBEL
Nell’anno 1911 l’Accademia delle Scienze di Stoccolma, volendo riconoscere i lavori importantissimi compiuti dalla scienziata dalla morte di suo marito in poi, le conferisce il Gran premio Nobel per la Chimica.
Mai un altro laureato, uomo o donna, non fu, e forse non sarà mai, ritenuto degno di ricevere due volte una simile ricompensa.
Così Maria si espresse nella conferenza pubblica in occasione della premiazione, riportando verso l’ombra del suo Pietro gli omaggi che salgono a lei : ”Prima d’accostarmi all’argomento della conferenza, ci tengo a ricordare che la scoperta del “radio” e quella del “polonio” sono state fatte da Pietro Curie in comune con me. Si devono anche a Pietro Curie , in questo campo della radioattività, studi fondamentali ch’egli ha effettuato sia solo, sia in comune con me……. credo dunque di interpretare esattamente il pensiero dell’Accademia delle Scienze ammettendo che l’alta distinzione di cui sono stata ritenuta degna è motivata da questa opera comune e costituisce perciò un omaggio alla memoria di Pietro Curie……”.
UN LABORATORIO DI RADIOATTIVITA’ A VARSAVIA
Nel 1912 nasce tra gli intellettuali polacchi il progetto grandioso di creare un laboratorio di radioattività a Varsavia e una loro delegazione si presenta a Maria con questa richiesta: “Si degni, onoratissima signora, di trasportare la sua splendida attività scientifica nel nostro paese e nella nostra capitale. Lei conosce le ragioni per cui, negli ultimi tempi, la nostra cultura e la nostra scienza hanno periclitato. Noi abbiamo perduto la fiducia nelle nostre facoltà intellettuali, ci siamo visti abbassati nell’opinione dei nostri nemici e abbiamo abbandonato la speranza nell’avvenire …… Il nostro popolo l’ammira, ma vorrebbe vederla lavorare qui, nella sua città natale …..”
Maria si reca a Varsavia nel 1913 per l’inaugurazione del padiglione di radioattività.
Di proposito, le autorità russe ignorano la sua presenza: nessuna personalità ufficiale prende parte alle feste organizzate in suo onore.
L’accoglienza di tutto il paese natale non è meno ardente per questo.
Per la prima volta in vita sua, Maria pronuncia in una sala stipata di gente, una conferenza scientifica in polacco.
LA GUERRA
Dice Maria in una sua lettera alle figlie lontane da Parigi: “Cara Irene, cara Eva, le cose sembrano volgere al peggio. La mobilitazione è cominciata e i tedeschi sono entrati in Francia senza dichiarazione di guerra……. I tedeschi attraversano il Belgio combattendo. Il bravo, piccolo Belgio non ha accettato di lasciarli passare senza difendersi……Il paese polacco è occupato dai tedeschi. Che cosa ne rimarrà dopo il loro passaggio ? ……”
Maria non ha che un pensiero : SERVIRE LA SUA SECONDA PATRIA. Nell’occasione terribile, una volta di più si rivelano le sua intuizione e la sua iniziativa.
Tutti sanno che la scoperta dei raggi X ha permesso d’esplorare, senza il soccorso della chirurgia, l’interno del corpo umano, di “vedere” e di fotografare le ossa e gli organi.
L’apparecchio magico grazie al quale, in un istante, su può scoprire e localizzare per “trasparenza” la palla di fucile, la scheggia di granata nascosti nella ferita.
Maria ha deciso subito, di slancio, di darsi concretamente da fare e in poche ore stende l’inventario degli apparecchi che esistono nei laboratori dell’università, compreso il suo, e fa un giro dai costruttori: tutto il materiale per i raggi X che può essere utilizzato è riunito e poi distribuito negli ospedali.
Manipolatori abili vengono reclutati tra i professori, gli ingegneri, gli scienziati.
Pensa e fa allestire inoltre tante “vetture radiologiche”. In molte automobili ordinarie ha disposto un apparecchio Roentgen e una dinamo che, azionata dal motore della vettura, fornisce la corrente necessaria. Questo posto mobile completo assicura l’esame radiologico dei feriti evacuati verso Parigi durante la battaglia della Marna.
Decide che rimarrà a Parigi, qualunque cosa accada. Il compito benefico che ha intrapreso non è il solo a trattenerla: essa pensa al suo laboratorio, agli strumenti delicati che si trovano nella sua università. “Se io sono presente” si dice, “forse i Tedeschi non oseranno danneggiarli. Ma se io me ne vado , tutto sparirà”.
Ha anche previsto che la guerra sarebbe stata lunga, che sempre più sarebbe stato necessario operare i feriti sul posto e che chirurghi e radiologi avrebbero dovuto essere a portata di mano, nelle ambulanze del fronte; ch’era urgente organizzare la costruzione intensiva d’apparecchi Roentgen, e infine che le vetture radiologiche sarebbero state chiamate a prestare servizi inapprezzabili. Queste vetture, soprannominate nelle zone di guerra le “piccole Curie”, Maria le attrezza a una a una nel suo laboratorio, senza preoccuparsi dell’indifferenza e della sorda ostilità dei burocrati.
Mai una donna celebre fu meno ingombrante di lei: mangia quello che c’è in qualunque posto; in una piccola stanza d’infermeria oppure all’aria aperta, sotto una tenda da campeggio. Senza sforzo, la studentessa di un tempo che tremava di freddo in una soffitta, è diventata un soldato della Grande Guerra.
Le figlie Irene ed Eva vivono presso a poco come figlie di combattenti : la loro mamma non si concede mai una “licenza”; se non è malata vuol dire che è a Suippes, a Reims, a Calais, a Poperingue ….., in uno dei tre o quattrocento ospedali francesi o belgi che visiterà durante le ostilità.
Maria, così spesso fredda e scostante, è, coi feriti, deliziosa. Qualche contadino, qualche operaio, si mostra spaventato dagli apparecchi Roentgen e chiede se l’esame gli farà male. Maria lo rassicura; “Vedrete, è come una fotografia”. Essa ha quello che può essere dolce per essi: un grazioso timbro di voce, mani leggere, molta pazienza, e un rispetto immenso, religioso della vita umana. Per salvare un uomo, per risparmiargli una sofferenza, un’amputazione, un’infermità, essa è pronta allo sforzo più stremante e non abbandona la partita che quando tutte le probabilità sono esaurite.
L’UTILIZZO DIE RAGGI X IN TUTTE LE STRUTTURE OSPEDALIERE
Con il suo nuovo mestiere Maria si mette in contatto son gli esseri più diversi.
Certi chirurghi che comprendono l’utilità dei raggi X, la trattano come un collaboratore prezioso, come un grande collega.
Altri, più ignoranti, considerano i suoi apparecchi con una sacra diffidenza. Dopo qualche radioscopia concludente, stupiranno che “la cosa funzioni” e crederanno appena ai propri occhi quando nel luogo rivelato dai raggi e designato da Maria essi incontreranno sotto il bisturi la scheggia invano cercata nella carne che soffre.
Allora, convertiti di colpo, commenteranno l’avvenimento come un miracolo ……
FINE DELLA GRANDE GUERRA
Per Maria con la fine della guerra ci sono due vittorie invece d’una.
La Polonia rinasce dalle sue ceneri, e dopo un secolo e mezzo di schiavitù, ridiventa un paese libero.
Quella che fu la signorina Sklodowska rivede la propria infanzia oppressa, le lotte della sua gioventù. Non è stato invano se, da bambina, ha lottato in dissimulazione, in astuzia coi funzionari dello zar, se ha raggiunto di nascosto, nelle povere stanzette di Varsavia, le sue compagne dell’”Università volante”, se ha insegnato a leggere ai contadini della sperduta campagna polacca.
Questi ricordi consolano ora Maria delle sue preoccupazioni. La guerra ha disorganizzato il suo lavoro scientifico. La guerra ha demolito la sua salute e l’ha rovinata economicamente; il poco denaro affidato al governo s’è sciolto come neve al sole, e quando esamina la propria situazione materiale, si sente stringere dall’angoscia: a cinquant’anni passati essa è quasi povera. Per vivere, per far vivere le figliole, non ha che il suo stipendio di professoressa.
L’AMERICA
Una mattina del maggio 1920, una signora è introdotta nella piccola sala d’attesa dell’Istituto del Radio. Si chiama signora William Brown Meloney e dirige a New York una grande rivista.
Maria la riceve nel suo laboratorio.
Così racconta l’incontro la signora William Brown: “La porta si aprì e vidi entrare una donna pallida e timida, col viso più triste che io abbia mai visto. Indossava un vestito di cotone nero. Da più di vent’anni io ero una giornalista professionista, e tuttavia non riuscivo a fare una sola domanda a quella donna senza difesa, vestita di cotone nero. Tentai di spiegare che gli americani s’interessavano alla sua grande opera e lei semplicemente per mettermi a mio agio disse che l’America possedeva cinquanta grammi di radio, quattro a Baltimora, sei a Denver, sette a New York …..”
“E in Francia ? “ domandai
“Il mio laboratorio possiede poco più di un grammo di radio”
“Lei non ha che un grammo di radio ?”
“Io ? Oh, io non ne ho punto. Questo grammo appartiene al laboratorio.”
“Allora io parlai del brevetto, degli utili che avrebbero dovuto fare di lei una donna molto ricca”
Essa mi disse tranquillamente: “il radio non deve arricchire nessuno . E’ un elemento. Appartiene a tutti.”
“Se lei potesse, nel mondo intero, designare una cosa di cui ha desiderio” domandai impulsivamente, “ che cosa sceglierebbe ?”
La signora Curie rispose, sottovoce: “Avrei bisogno d’un grammo di radio per continuare le mie ricerche, ma non posso acquistarlo: il radio è troppo caro per me”.
Naturalmente negli Stati Uniti nulla è impossibile.
La signora William creerà un comitato apposito e la cifra per acquistare il grammo di radio viene trovata immediatamente. Specialmente le donne furono generose.
La signora William Brown invita poi caldamente Maria a recarsi di persona in America dove il dono del grammo di radio lo potrà ricevere dalle stesse mani del Presidente degli Stati Uniti.
La signora Curie è commossa. Domina però i suoi timori e, a cinquantaquattro anni, accetta, per la prima volta in vita sua, gli obblighi di un grande viaggio ufficiale, insieme alle figlie Irene e Vera.
AH! COME SONO STANCA!....
“Sono davvero stanca !”. Quasi ogni sera una Maria Curie dal volto pallido, che la stanchezza diminuisce e invecchia, mormora questa frase.
Essa ha lasciato il laboratorio assai tardi, alle sette e mezzo, talvolta alle otto.
Non servirebbe a nulla che sui figlia le dica: “Tu lavori troppo. Una donna di settantacinque anni non può, non deve lavorare come fai tu”. Eva sa benissimo che la signora Curie è incapace di lavorare meno, che questa testimonianza di ragionevolezza sarebbe per lei il segno terribile della decrepitezza. Il solo augurio che si possa fare la ragazza è che, ancora per molto tempo, sua madre trovi la forza di lavorare quattordici ore al giorno.
In quella torre di Babele ch’è l’Istituto del Radio, s’alternano studiosi di diverse nazionalità. Tra cui c’è sempre un polacco. Quando la signora Curie non può accordare a un compatriotta una borsa di studio senza ledere qualche giovanotto più meritevole, paga del suo gli studi dello studente venuto da Varsavia, che ignorerà sempre questa liberalità.
Molte volte si china verso la figlia dicendo: “Suvvia, cara…… raccontami qualche cosa. Dammi notizie di questo mondo!” Le si può parlare di tutto, anche e soprattutto di cose puerili.
I commenti soddisfatti di Eva sui “70 di media” raggiunti dalla sua vettura trovano in Maria l’uditore più comprensivo. Qualche aneddoto sulla sua nipotina Elena, una parola della bimba, la fanno improvvisamente ridere sino alle lacrime, d’un riso giovanile inaspettato.
Essa sa anche parlare di politica senza arrabbiarsi e come vecchia “progressista” si lamenta che la Francia manchi d’ospedali e di scuole, che migliaia di famiglie abitino in case antigieniche, che i diritti della donna siano precari …. Tutti pensieri che la torturano.
Questi anni brillanti, fecondi, sono anche anni di lotte drammatiche. La signora Curie è minacciata di cecità. Il medico le ha appreso nel 1920 che una doppia cateratta avrebbe creato a poco a poco intorno a lei l’oscurità. Maria non ha lasciato vedere la sua disperazione ed ha preteso che non se ne parli a nessun e che soprattutto che la voce non si spanda.
FINE DELLA MISSIONE
Accade sovente alla signora Curie di parlare della sua morte.
Essa commenta con calma apparente l’avvenimento ineluttabile con frasi come questa: “E’ evidente ch’io non posso più vivere a lungo e la sorte dell’Istituto del Radio quando io non ci sarò più, mi preoccupa”.
Per difendersi contro l’aggressione che teme, costruisce febbrilmente intorno a sé un baluardo di progetti, di doveri.
Essa sprezza una stanchezza ogni giorno più evidente, e i mali cronici che l’opprimono: la sua pessima vista, un reumatismo nella spalla, i lancinanti ronzii nell’orecchio.
Essa si sente stanca ma ci tiene a dimostrare a se stessa che non è malata.
Va a pattinare a Versailles, raggiunge Irene sui campi di sci della Savoia e a Pasqua organizza con Bronia un viaggio in automobile nel Mezzogiorno.
La spedizione però è disastrosa. Maria ha voluto fare grandi giri, mostrare a sua sorella molti paesaggi ma quando raggiunge, dopo varie tappe, la città di Cavalaire Maria è scossa da brividi con febbre e s’abbandona a un tratto a una crisi di disperazione. Singhiozza nelle braccia di Bronia, come una bimba malata. E’ ossessionata dal suo libro e teme che la bronchite possa privarla della forza necessaria per terminarlo.
Un medico ha parlato d’influenza e – come tutti i medici da quarant’anni a questa parte - di stanchezza.
Maria ondeggia tra la malattia e la salute. I giorni in cui si sente meglio va al laboratorio. Quando è stordita, indebolita, rimane in casa e lavora al proprio libro.
Ma la subdola nemica la vince in velocità. La febbre si fa sempre più insistente, i brividi più violenti.
Eva deve impiegare una pazienza da diplomatico affinché sua madre acconsenta a ricevere un nuovo dottore. Questa scienziata, questa amica del progresso, è recalcitrante alle cure come una contadina.
Il professor Régaud viene a fare a Maria una visita amichevole, la consiglia di chiedere il parere di un suo amico, il dottor Raveau, il quale a sua volta raccomanda il dottor Boulin, medico degli ospedali. La prima parola di quest’ultimo, scorgendo il viso esangue di Maria, è: “Lei deve restare a letto, riposare”.
La signora Curie ha udito già tante volte queste esclamazioni ed è abituata a non preoccuparsene.
Scende a risale la faticose scale della casa sul lungofiume, lavora quasi ogni giorno all’Istituto del Radio.
In una giornata piena di sole del maggio 1934, rimane fino alle tre e mezzo nella sala di fisica, sfiora stancamente le capsule, gli apparecchi, suoi fedeli compagni. Scambia qualche parola coi suoi collaboratori. “Ho un po’ di febbre” mormora. “Rincaserò”.
Essa non si alza più dal letto. Una lotta scoraggiante contro un male impreciso, designato prima come influenza, poi come bronchite, la condanna a cure stremanti.
Essa le sopporta con un’improvvisa , una spaventosa docilità, e accetta d’esser trasportata in una clinica per sottoporsi a un esame completo.
Due radiografie, cinque o sei analisi, lasciano perplessi gli specialisti che sono stati chiamati al capezzale dell’ammalata.
Nessun organo sembra colpito, nessuna malattia caratterizzata si rileva.
Si comincerà a pronunciare intorno a lei la parola “sanatorio”. Eva le suggerisce timorosamente l’idea di questo esilio. Anche questa volta, Maria obbedisce, accetta la partenza. Essa ripone la sua speranza in un’aria più pura, s’immagina che la polvere e il rumore della città le impediscano di guarire.
Al sanatorio non deve ricevere più che pochi intimi ma tuttavia Maria sfida le consegne , fa chiamare di nascosto in camera sua una collaboratrice, la signora Cotelle, e le prodiga le raccomandazioni. “Bisogna chiudere accuratamente l’attinio, metterlo al riparo sino al mio ritorno . Conto su di lei per mettere tutto in ordine. Riprenderemo il lavoro dopo le vacanze.”
La febbre sorpassa i quaranta gradi.
Non si può nascondere questa cifra a Maria che, con cura scientifica, controlla sempre da sé il livello del mercurio. Non dice quasi nulla, ma i suoi occhi impalliditi rivelano una grande paura.
Gli ultimi momenti rivelano la forza, la resistenza terribile d’un essere la cui fragilità non era che apparente, d’un cuore robusto, nascosto in una carne dalla quale il calore sfugge, e che continua a battere, instancabilmente, implacabilmente.
Per sedici ore ancora il dottor Pierre Lowys ed Eva tengono ciascuno una delle mani gelide d’una donna che né la vita né il nulla sembrano volere.
Dinanzi a questo cadavere la scienza deve ancora pronunciarsi.
I sintomi normali, gli esami del sangue, diversi da quelli delle anemie perniciose conosciute, denunciano il vero colpevole: il radio.
“La signora Curie va annoverata tra le vittime a lunga scadenza dei corpi radioattivi, che suo marito ed essa hanno scoperto” scriverà il professor Régaud, “La malattia è un’anemia perniciosa aplastica a decorso rapido, febbrile. Il midollo osseo non ha reagito, probabilmente perchè alterato da una lunga accumulazione di radiazioni”.
UNA DIPARTITA DA GRAN SIGNORA DELLA SCIENZA
Dinanzi agli apparecchi inerti dell’Istituto del Radio, i giovani scienziati singhiozzano. George Fournier, uno degli allievi preferiti, scriverà: “Noi abbiamo perduto tutto”.
La signora Curie riposa al riparo da questi dolori, al riparo dalle agitazioni e degli omaggi, sul suo letto di Sancellemoz, in una casa nella quale uomini di scienza pieni di devozione, suoi eguali, l’hanno protetta sino alla fine.
Nessuno straniero è ammesso a turbare, sia pure con uno sguardo, il suo riposo. Nessun estraneo saprà di quale soprannaturale grazia essa s’è adornata per questa partenza.
Vestita di bianco, coi capelli bianchi rialzati a scoprire la fronte immensa, e valente come un cavaliere, essa è in questo momento quel che v’è di più bello, di più nobile sulla Terra.
Le sue mani ruvide, callose, indurite, profondamente bruciate dal radio, hanno perso il loro tic familiare. Esse sono allungate sul lenzuolo, rigide, atrocemente immobili. Le sue mani che hanno tanto lavorato !
Il venerdì 6 luglio 1934, senza discorsi, senza corteo, senza politica, senza un personaggio ufficiale, la signora Curie prende modestamente il suo posto nella dimora dei morti.
Essa è inumata dinanzi ai suoi cari, agli amici e ai collaboratori che l’amavano. La sua bara è posta al disopra di quella di Pietro Curie.
Un anno dopo, il libro che Maria aveva terminato prima di scomparire porta ai giovani “innamorati della fisica” un ultimo messaggio.
All’Istituto del Radio, dove il lavoro è ricominciato, l’enorme volume è venuto ad aggiungersi, nella chiara e luminosa biblioteca di Maria, alle altre opere scientifiche.
Sulla copertina grigia, il nome dell’autore: Madame Pierre Curie – Professeur à la Sorbonne – Prix Nobel Physique – Prix Nobel de Chimie, e il titolo, fatto d’una sola parola, severa, raggiante:
Radioattività
Piazza Pizzigoni, 5 - 56028 San Miniato Basso (PI)